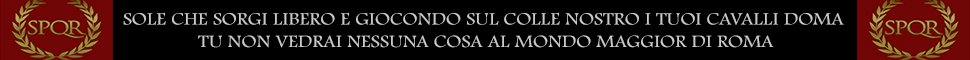Categorie Virgolettato Scritto da r. cdr giovedì, 15 Novembre alle ore 11:44
|
Da: La Repubblica Riportiamo questa interessante riflessione tratta dal quotidiano “La Repubblica”. Quattro italiani su dieci “tifano” per una squadra. Di questi, oltre la metà non si limita ad “amare”, ma, al tempo stesso, “odia” un’altra formazione. Fino a ieri, principalmente la Juventus. Oggi, anche l’Inter. I vecchi e nuovi “potenti”. Questo Paese di “tifosi”, sminuzzato da innumerevoli esibizioni di odio e amore. In un mosaico di bandiere e di colori. Che si ricompongono, immancabilmente, di fronte a un comune nemico. Lo Stato. Le sue istituzioni. (Che, a loro volta, disorientano. Perché alternano deficit di autorità a episodi di arbitraria violenza). L’Italia: un Paese in curva, abbiamo scritto tempo fa. Dove non c’è spazio per i moderati, per il fair play. Per il rispetto reciproco, per il dialogo. Facile tracciare paralleli, coincidenze, connessioni, legami. Fra calcio e società. Ribadire che il calcio è lo specchio della società. Però, è anche deviante. Comunque, parziale. Oggi, in particolare, a noi pare più vero il contrario. E’ il calcio che offre alla società uno specchio deformante. Perché è divenuto uno spettacolo dominante. Sovrano dei palinsesti mediatici. Garantisce ascolti stratosferici. Non solo nelle grandi occasioni. Quasi sempre. Fanno ascolti altissimi: la nazionale, le grandi squadre e quelle piccole. I campionati mondiali, quelli europei, quelli nazionali, la Champions League, i tornei estivi. Persino i trofei amatoriali e le partite giocate per beneficenza: attori contro cantanti, piloti contro giornalisti, preti contro atei. Lo stadio è divenuto un’arena mediatica, dove sono in gioco non la vittoria di un torneo, uno scudetto. Ma identità, appartenenze. Che si scontrano, con regolare ferocia. Ormai, anche le poche settimane di luglio in cui il calcio si riposa, diventano difficili. Generano diffuse crisi da astinenza. Non solo per ragioni di business. Visto che il calcio in tivù è un affare iperbolico. E non solo per i “tifosi”. Ma, perché, senza il calcio, questo Paese perde la bussola e il sentimento. Senza il calcio: questo Paese sembra quasi perdere l’anima. Il soffio. Non resta che andare in vacanza. Ascoltare distrattamente le cronache dal mondo, che echeggiano sanguinosi scontri di civiltà. Lontani. In attesa di quelli, più coinvolgenti e vicini. Alla ripresa del campionato e di quel che lo precede. Per questo, il calcio, in tivù, non è più solo “spettacolo”, definito da ciò che avviene in campo. Ma, come ha sottolineato Alessandro Dal Lago, mima, evoca le cadenze, le forme di una “battaglia”. Condotta nello spazio “simbolico” (ma non solo) definito dallo stadio. Le squadre che si oppongono e combattono, in campo. Affiancate dalle tifoserie. Soprattutto in curva. Dove operano le “avanguardie”: gli ultrà. Quelli che si menano tra loro, urlano cori razzisti e odiosi. Sparano razzi, lanciano oggetti. Quelli verso cui si lanciano, dopo ogni gol, i giocatori. Non per insultarli. Al contrario: per “celebrare” insieme il rito comune della vendetta, della guerra. Della vittoria e della rivincita. Contro tutti quanti. Gli ultrà, di questa rappresentazione, non costituiscono una frazione deviante, marginale e deprecata. Interpretano, al contrario, una parte da protagonisti. Personaggi di primo piano. Il fatto che siano infiltrati, talora guidati da gruppi politici estremisti, soprattutto di destra (ma, in alcuni stadi, anche di sinistra), non è un incidente. Al contrario: è un requisito, una condizione. Perché gli “estremisti” sono professionisti della protesta, dell’aggressione, dell’antagonismo. Dell’identità esibita, rivendicata e gridata. Contro tutti. Contro altre identità. Norbert Elias, non a caso, ha definito lo sport “una battaglia controllata all’interno di uno scenario immaginario. In altri termini: un luogo nel quale la società (moderna) scarica le sue pulsioni più violente. “Delimita” l’aggressività che la attraversa. Il problema è che, oggi, quell’aggressività e quella violenza, invece di essere circoscritte dagli stadi, esaurite dalle partite, tracimano. Si disseminano intorno. Negli spazi circostanti. Ma anche altrove. Nelle autostrade, nei quartieri delle metropoli e delle città. Accendono focolai un po’ dappertutto. Il calcio, per questo, oggi non è più specchio della società. Semmai, è vero il contrario. La società si specchia nel calcio. Ne assorbe gli umori, le tensioni, le violenze. Per poi ritrarsi. Prendere le distanze. Denunciarne la degenerazione. Urlare contro le frange violente. I pochi esagitati estremisti che tengono in ostaggio tutto e tutti. Il calcio – sentiamo ripetere dovunque, come un mantra – non coincide con gli “ultrà”. Neppure i tifosi. Tanto meno la società. Troppo facile. Troppo semplice. Autoassolutorio. Per i tifosi, per il calcio e per la società. Invece noi pensiamo che oggi nel tifo, nel calcio, nella società e in (quasi) tutti noi si annidi un ultrà. Dissimulato. Inconfessato. Ma, in tempi “normali”, neanche troppo. Poi, quando esplode, incontrollato, arretriamo. Ne prendiamo le distanze. Troppo spaventati, per ammettere. Di averlo, a lungo, nascosto, tollerato, coltivato. In modo complice e indulgente. |