Categorie Virgolettato Scritto da Lucky Luke giovedì, 8 Maggio alle ore 11:01
|
da La Repubblica – romanews.eu
Garcia, lo sa con quale città europea è gemellata da più tempo con Lilla? Torino, dal 1958. E quindi? Lei ci ha creduto davvero a un possibile sorpasso o era un modo per tenere la squadra sulla corda? Catania, un brutto scivolone. Un altro avrebbe detto entusiasmante, oppure, aggettivo di gran moda, importante. Ma lei, Garcia, dà l’impressione di controllarsi molto, di essere un freddo. Lo sa chi era? E’ stato uno dei fondatori del Pcf, per 40 anni ha diretto l’Humanité. Al Père Lachaise la sua tomba è accanto a quella di Paul Eluard, e da lì si vede anche quella di Edith Piaf. «A me piace molto Aznavour ». La mia esibizione di cultura franco-cimiteriale non l’ha molto impressionato. Ritento la scalata da un altro versante. Gli dico che ho letto la sua biografia, scritta con Denis Chaumier, e dopo 239 pagine ne sapevo quasi meno di prima. Ma spesso depistando. So i titoli dei libri che leggeva sua sorella Sandrine, ma niente di quelli che leggeva lei. So che suo padre Josè è stato calciatore e poi allenatore, esattamente come lei. Ma non ho trovato due righe su quello che il padre ha consigliato al figlio calciatore o al figlio allenatore. Non le pare strano? Perché? Quando ha cancellato l’idea del veterinario? Secondo me nella rinuncia all’idea del veterinario c’è anche una sua ipersensibilità a circostanze ospedaliere. Una debolezza, se vuole. Quando va trovare suo padre operato alla mascella, impressionato dai fili che la tengono insieme corre in bagno a vomitare. Da buon padre, assistendo alla nascita della sua prima figlia, sviene. Sì, ma in questo momento il libro da sfogliare è lei. Nel calcio, campo e panchina, lei è raccontato come un uomo forte, anche in situazioni difficili. Uno deciso, tutto d’un pezzo. Ma, fuori calcio, con le sue fragilità. Ho detto bene? Se lei dovesse spiegare il suo mestiere a una classe di bambini delle elementari, cosa direbbe? Ai giornalisti invece ha detto che un allenatore dev’essere un attore. Educatore no? Se uno dei suoi giocatori fa una cazzata, una connerie per dirla in francese, lei come si regola? Altre abitudini? Li ha sempre chiamati per nome, i giocatori, o è una novità romana? Che cosa l’ha colpita di più, nel nostro calcio? Lo rifarebbe? Sì. Che altro? Cosa fa male al calcio? Amori calcistici? Il gol più bello? Questo ballottaggio tra sublimare ed esaltare la dice lunga su Garcia, che ci tiene non solo a conoscere bene l’italiano, ma anche alle sfumature. Alla consegna del premio Prisco, a Chieti, stupì i presenti usando la parola parametri. Ogni tanto si fa dire una parola gergale da qualcuno dell’ufficio stampa e poi la approfondisce per conto suo, visto che di notte continua a studiare l’italiano. Suggeritagli la parola paraculo, e approfonditala, protestò il giorno dopo. Forse pensava a qualcosa di protettivo, come il parebrise di Conte (Paolo) o i parepluie di Cherbourg e di Brassens. Se c’è un argomento su cui si può stanare Garcia è il vino. Nel libro racconta di come Pallotta li abbia affascinati, lui e il suo braccio destro Fred Bompard, non solo col piano di sviluppo giallorosso ma sganciando due bottiglie di Romanée Conti 1988 a Garcia e due di Dom Perignon a Bompard, «che beve solo Champagne». Perché, posto che nella vita c’è di peggio? Ma scusi, se Fred avesse lavorato a Evian berrebbe solo acqua minerale? Nel libro lei dichiara: non sono mai contento di quello che ho. Non le sembra un’autocondanna all’infelicità? Appunti in ordine sparso. È un pastasciuttaro convinto (cacio e pepe, amatriciana). Più pesce che carne. Tiramisù e dolci al cioccolato (da ragazzo aveva anche provato a cucinarli). Gli è molto piaciuta Gerusalemme. A Roma ha già visitato i Musei Vaticani, la Cappella Sistina, la Sala del Pianto e la Garbatella. Sul Gianicolo va di notte, quando c’è meno gente, per godersi il panorama. Si dice stia cercando casa all’Aventino, ma questi sono affari suoi e non ho approfondito. G. Mura |
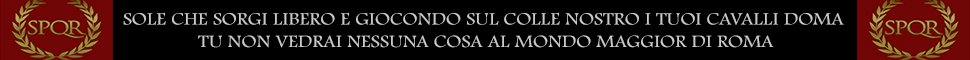



 Rudi Garcia ci riguarda (anagramma). Ci riguarda perché è il primo francese ad allenare in serie A e per giunta ad allenare una squadra devastata nel rendimento, umiliata e criticata a sangue dai suoi stessi tifosi, quindi candidata a un rapido e inglorioso fallimento. In teoria. In pratica, Garcia ha firmato un capolavoro anche se, naturalmente, ci tiene a dividere i meriti con tutti. Avevo in mente una domanda da fargli per rompere il ghiaccio: quali differenze fra Trigoria e Luchin, il centro d’allenamento del Lilla? Sono zone che conosco abbastanza, per via del ciclismo. Luchin è un impianto all’avanguardia, che si sviluppa intorno a una fattoria lunga e bassa dell’800. È vicinissimo al Carrefour de l’Arbre, dove comincia la zona di pavé più dura nella Parigi-Roubaix. Cancello la domanda man mano che il taxi s’avvicina a Trigoria, in uno scenario da Roma pasoliniana: donne più o meno vestite in mostra a ogni slargo, il ciglio della strada ininterrottamente segnato da sacchetti di spazzatura, bottiglie di plastica, brandelli di copertoni, stracci, rifiuti assortiti, un potente e annoso inno alla sporcizia. La cancello anche perché ne ho una di riserva Rudi.
Rudi Garcia ci riguarda (anagramma). Ci riguarda perché è il primo francese ad allenare in serie A e per giunta ad allenare una squadra devastata nel rendimento, umiliata e criticata a sangue dai suoi stessi tifosi, quindi candidata a un rapido e inglorioso fallimento. In teoria. In pratica, Garcia ha firmato un capolavoro anche se, naturalmente, ci tiene a dividere i meriti con tutti. Avevo in mente una domanda da fargli per rompere il ghiaccio: quali differenze fra Trigoria e Luchin, il centro d’allenamento del Lilla? Sono zone che conosco abbastanza, per via del ciclismo. Luchin è un impianto all’avanguardia, che si sviluppa intorno a una fattoria lunga e bassa dell’800. È vicinissimo al Carrefour de l’Arbre, dove comincia la zona di pavé più dura nella Parigi-Roubaix. Cancello la domanda man mano che il taxi s’avvicina a Trigoria, in uno scenario da Roma pasoliniana: donne più o meno vestite in mostra a ogni slargo, il ciglio della strada ininterrottamente segnato da sacchetti di spazzatura, bottiglie di plastica, brandelli di copertoni, stracci, rifiuti assortiti, un potente e annoso inno alla sporcizia. La cancello anche perché ne ho una di riserva Rudi.